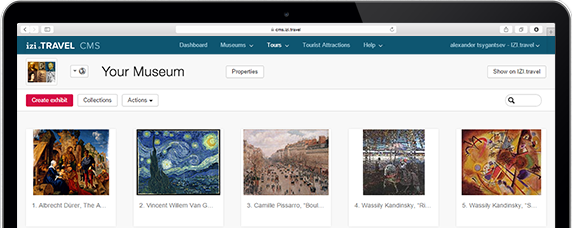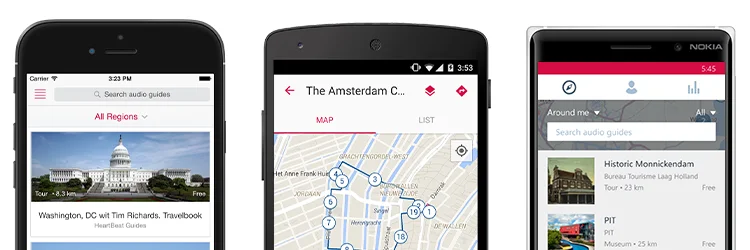Fondazione Horne
Immaginate un palazzo del Quattrocento fiorentino dove i nobili proprietari abbiano lasciato, ben ordinate, le molte cose belle acquistate nel corso della loro vita: cassoni istoriati, tarsie, maioliche, bronzetti, suppellettili, e ancora sculture e pitture su tavola, tra le quali alcuni assoluti capolavori come il Santo Stefano di Giotto. È il museo Horne, frutto dell’amore che un colto e raffinato inglese, Herbert Percy Horne, ebbe per la città di Firenze e per l’Italia, alla quale donò nel 1916 quanto aveva raccolto nel corso degli anni con grande gusto e intelligenza.
Nel quartiere di Santa Croce, a pochi passi dall’omonima basilica, in una zona segnata dalle torri medioevali della famiglia Alberti, Horne aveva acquistato questo palazzo, già proprietà dei Corsi, che oggi accoglie il visitatore dopo un lungo restauro diretto dallo stesso collezionista, volto a riportarlo alla sua originaria dimensione quattrocentesca, frutto dei lavori diretti da Simone del Pollaiolo detto il Cronaca (lo stesso architetto del noto palazzo Strozzi). Passato l’androne e attraversata la corte allietata da un loggiato, ammirati gli elaborato capitelli e i prospetti interni decorati da graffiti, ad introdurre alla visita delle sale è lo stesso Herbert Horne. Una suggestiva videoinstallazione ospitata nella camera terrena del palazzo vede infatti il collezionista raccontare in prima persona della sua vita e della decisione di abbandonare la Londra del tardo Ottocento nella quale frequentava Oscar Wilde e Dante Gabriele Rossetti per farsi fiorentino d’adozione e trasformarsi, da dandy vittoriano, in uomo del Rinascimento.
I piani superiori, che ospitano le collezioni del museo, consentono di seguire tre possibili itinerari, o meglio tre temi strettamente legati tra loro.
Vi è innanzitutto la casa, con i suoi camini, i soffitti intagliati, i pavimenti di cotto antico, le finestre chiuse da scuri chiodati e invetriate piombate… che bene documenta quella che era l’organizzazione degli ambienti secondo i precetti rinascimentale: qui si trovano infatti applicate molte delle raccomandazioni che Leon Battista Alberti aveva dato nei suoi scritti al fine di rendere le dimore dei ceti dirigenti le più accoglienti e funzionali, dalla presenza del pozzo interno ai “luoghi ritirati” sistemati in prossimità delle camere. Le sale e le camere (cioè la casa vera e propria dove un tempo viveva la famiglia Corsi) sono disposte lungo i fronti principali del palazzo, aperti all’aria e alla luce del sole. Nella parte più interna sono invece gli ambienti che un tempo erano le celle per conservare le masserizie, le cucine (una per piano in modo da offrire un servizio ottimale ai signori ovunque questi decidessero di pranzare) e gli alloggi della servitù.
In questa casa, poi, il visitatore incontra le opere d’arte, che certo vivono in simbiosi con l’ambiente ma che sono in molti casi capolavori assoluti da ammirare singolarmente. Così è per la già ricordata tavola con il Santo Stefano di Giotto, accanto alla quale non si potranno comunque dimenticare un dittico con la Pietà di Simone Martini, un trittico di Pietro Lorenzetti, una Storia di San Giuliano di Masaccio, la grande tela con la Deposizione di Cristo di Benozzo Gozzoli (ultima opera del maestro), la Sacra Famiglia di Domenico Beccafumi. E ancora opere di Bernardo Rossellino, Filippo Lippi, Dosso Dossi, Giambologna, Sansovino. A questi capolavori fanno riscontro arredi e suppellettili di non minore importanza nel documentare la dimensione domestica e la civiltà dell’abitare nella Firenze del Rinascimento: cassoni, cassette, strumenti per misurare il tempo e le distanze, utensili da lavoro, accessori femminili, fino a giungere (esposta nella cucina superiore del palazzo) a una estesa collezione di posate con esemplari dall’età romana fino a tutto il Seicento.
Su questi due nuclei d’interesse si intreccia il terzo tema, strettamente legato alla figura di Herbert Horne e al suo particolare modo di leggere e rivivere quest’età passata, indagata con lo scrupolo dello studioso ma amata con il cuore di un poeta, tanto da giungere a usare quegli stessi calici e quelle posate antiche per i suoi frugali pasti, passeggiando nelle sale dove aveva raccolto, oltre alle molte opere d’arte, disegni, carte d’archivio, medaglie, monete, tessuti ricamati, e che aveva pensato di lasciare ai posteri per fare della sua dimora un luogo di studio e di incontri …
Con l’intento di tener vivo il sogno del suo fondatore (che fu appunto quello di condividere con gli altri la sua passione), il Museo Horne organizza visite a tema dedicate alla vita quotidiana nel palazzo, al banchetto rinascimentale, alle tecniche artigianali antiche, e a quanto attiene alla cultura e all’arte della Firenze tra Quattrocento e Cinquecento.
Ladda ner appen izi.TRAVEL gratis
Skapa dina egna ljud-turer!
Användningen av systemet och den mobila guide-appen är helt gratis