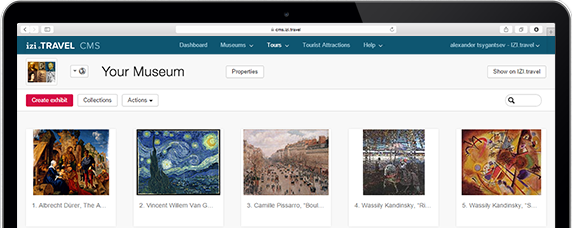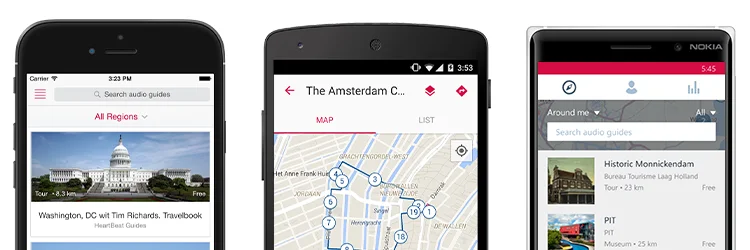Om museet
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your
Flash plugin.
Istituito nel 1927 e aperto al pubblico nel 1928, nel 1964 fu trasferito nel complesso di San Benedetto, restaurato dall’architetto Ezio De Felice. Oltre ai resti del quadriportico della chiesa di S. Benedetto, che scandiscono l’esposizione al pianterreno, sono visibili i resti del loggiato del Castelnuovo Reale. Sotto il livello stradale sono i resti della fortificazione longobarda (VIII secolo).Il viridarium accoglie reperti lapidei di epoca romana, rinvenuti in città fin dal Seicento, come una Venere con delfino e copie romane dell’Afrodite Cnidia di Prassitele e della cosiddetta “Grande Ercolanense”. Una base marmorea del I sec. d.C. a bassorilievo raffigura probabilmente l’arrivo trionfale in città di un importante personaggio. Il pianterreno espone i reperti provenienti da varie località, esemplificazione delle correnti culturali che improntarono il Salernitano dalla preistoria all’età romana. Trovano posto campionature di materiali esposti negli altri Musei della Provincia (Padula, Nocera Inferiore, Oliveto Citra).La prima sezione, dedicata alla preistoria, ospita reperti faunistici da Eboli e strumenti di industria litica da Amalfi e Palinuro; sono esposti poi materiali databili tra il paleolitico e l’età del bronzo, provenienti dalle grotte di Polla e Pertosa. Tipica dell’età del ferro è la “cultura delle tombe a fossa” documentata dalle sepolture della valle del Sarno e da Oliveto Citra: i defunti erano sepolti direttamente in fosse terragne ricoperte da ciottoli. Accanto alla pratica dell’inumazione, altre tombe testimoniano l’esistenza del rituale funerario dell’incinerazione del defunto che si ricollega alla cultura villanoviana. Le tombe maschili sono corredate da fibule, rasoi e armi di bronzo; le femminili da spille, collane d’ambra e utensili legati alla filatura. I corredi di due tombe da Sala Consilina dell’orientalizzante mostrano l’ornamentazione femminile, con numerose spille, tra cui alcune rivestite di ambra e osso, collane di ambra, orecchini, armille a spirali, sonagli, pendagli di vario tipo e centinaia di borchiette cucite sulle vesti. L’orientalizzante è ben rappresentato dai corredi delle tombe di Pontecagnano e dell’Arenosola, località a 5 km dalla riva destra del Sele. L’evoluzione stilistica della produzione vascolare nel passaggio tra VII e VI sec. a.C. si può cogliere osservando i corredi delle tombe di Sala Consilina, con la comparsa di nuove forme come i kernoi, supporti fittili a cerchio sormontati da piccoli kantharoi. Anche Palinuro è presente con alcuni reperti di VI sec. a.C., tra cui la coppa con la caratteristica decorazione “ad occhioni” con valore apotropaico. Il V sec. a.C. è documentato dai reperti di Atena Lucana e Buccino con le caratteristiche nestorides e da Nocera Superiore con corredi che rimandano al Museo di Nocera Inferiore. Da Roscigno proviene il corredo di una tomba principesca. Seguono materiali dall’agro picentino- pestano, tra cui vasi figurati, databili al IV sec. a.C., come il cratere a campana attribuito ad Assteas. Nel percorso museale sono stati inseriti due spazi dedicati al costume maschile e a quello femminile: da una parte elmi e cinturoni, dall’altra specchi e oggetti di ornamento femminili, come bellissimi pendagli in ambra. Ricca è la sezione che espone le collezioni private donate nel tempo alla Provincia, come la Collezione Boezio da Sala Consilina (in parte al Petit Palais di Parigi). Le collezioni Foglia da Montecorvino Rovella e Gatti da Ottati sono caratterizzate da un numero elevatissimo di bronzi. Al IV-III sec. a.C. risale un gruppo di vasi a vernice nera sovraddipinti da Pontecagnano, detta serie di “Gnathia”, città dell’Apulia. La visita del pianterreno si conclude con Salerno romana. Il materiale (olle, boccali, coppette, unguentari vitrei, lucerne da una officina locale) proviene dalle tombe rinvenute lungo il corso Vittorio Emanuele di Salerno, dov’erano le necropoli dell’antica Salernum. L’esposizione dedicata all’epoca romana continua al piano superiore dove è esposta una testa bronzea, alta 51 cm. e databile tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C., ripescata nel golfo di Salerno. Il resto del primo piano vede l’esposizione dei materiali provenienti dall’insediamento etrusco-sannitico di Fratte, a est della città di Salerno, le cui principali fasi di vita sono comprese tra il VI e il III sec. a.C. La documentazione è rappresentata dai reperti dall’abitato, con terrecotte architettoniche figurate, tra cui antefisse, acroteri, sime, e materiale lapideo e dalle necropoli con corredi tombali che vanno dal VI al IV sec. a.C. Tra questi materiali spiccano vasi greci figurati di eccezionale qualità e oggetti come ambre, fibule, pendagli in bronzo, orecchini e anelli. Pochi sono i corredi delle tombe di IV e III sec. a.C., i maschili contrassegnati da armi e cinturoni in bronzo, quelli femminili da vasi come la lekane, una coppa con coperchio, recipienti per unguenti e profumi, e il lebes gamikos, vaso donato per le nozze.